di Giacomo Sartori

È sempre un compito penoso ricordare chi se ne è appena andato. Diciamo la verità, quando muore qualcuno ci si dice che sarebbe potuto benissimo capitare a noi, o insomma che i prossimi della lista forse siamo noi, senza che lo subodoriamo. Si ha quel brivido lungo la schiena di quando un grosso vaso salpato da un decimo piano ci sfiora la tempia, soffiandoci sulla pelle un’arietta di gelida fatalità. Tanto più quando il defunto ci era prossima per età e abitudini, più che prossima, quasi una controfigura, e quindi lo scambio dei destini non appare poi così improbabile. E a ben vedere anche le considerazioni che si tirano fuori nei necrologi risentono di questa inconfortevole sensazione di prossimità della morte. Si arbora la mestizia, ma grattando bene sotto la tristezza affiora la strizza. Questa è la tipica frase sentenziosa che avrebbe potuto mettere lì lui, detto per inciso. Si parla di un’altra persona, uno che adesso è deceduto, ma si pensa a sé stessi, al panico di non lasciare nulla dietro, di non valere nemmeno un onesto necrologio su un quotidiano di provincia. La morte naturalmente spaventa, ma terrorizza ben di più la contabilità conclusiva che essa implica. Un po’ come l’uscita da un ristorante costosetto dove ci siamo abbuffati, avrebbe commentato lui, con la sua dizione sempre un po’ impastata.
Nel caso di Giacomo Sartori le acque sono ancora più melmose, chiunque abbia avuto modo di conoscerlo da vicino può confermarlo. Non è semplice scrivere il necrologio di una persona che tutti sanno essere stata molto spiacevole (avevo quasi la tentazione di usare il presente, quasi i suoi difetti si perpetuassero anche dopo il decesso). La realtà è che sotto il suo fare mellifluo e gentile, quasi sottomesso, era un gran rompicoglioni, un arrogante sputasentenze, nemmeno i salti mortali retorici più arrischiati potrebbe nasconderlo. Un inguaribile megalomane, direbbe qualcuno. Con questo non voglio censurare le sue qualità letterarie, intendiamoci. Ma in tutte le cose, anche nel cercare il buono, c’è una misura, vanno messi dei limiti.
Un necrologio vale qualcosa se dice la verità, anche se forse non tutta la verità, lui sarebbe il primo a darmi ragione. Confesso allora che farei molto volentieri a meno di confezionare il suo. Devo essere franco, avrei preferito che fosse qualcun altro a decantare quell’incostante personaggio del quale volente o nolente ero un intimo (amico forse è dire troppo, visto il suo carattere). O meglio, se davvero voglio essere totalmente sincero, costi quel che costi, e come lui avrebbe appunto voluto (stavo per dire “vorrebbe”) che fossi, se insomma cerco di essere per una volta all’altezza delle sue smodate aspettative letterarie (un necrologio è pur sempre letteratura, su questo lui stesso avrebbe insistito), devo confessare che ho cercato in tutti i modi di sottrarmi. Il direttore del giornale locale però ha insistito, mi ha convocato nel suo spazioso ufficio per dirmi che nessuno può parlare di lui come posso farlo io, che lo frequentavo da sempre.
Ma dobbiamo per forza parlarne?, gli ho chiesto io, guardando nel fondo dei suoi occhi mai sazi della pedissequa ripetitività della provincia. Lui mi ha fissato senza sapere se scherzavo o meno, perché effettivamente ogni tanto sparo fuori delle battutacce di dubbio gusto, anche un po’ macabre. Scandendo le parole come si fa con i portatori di deficienza mi ha detto che era pur sempre uno dei pochi scrittori di origini locali che ha sempre pubblicato con editori nazionali, diversi suoi romanzi sono stati tradotti in altre lingue, alcuni hanno ricevuto dei premi internazionali. Certo ha vissuto quasi tutta la sua vita in una capitale straniera, e non è mai stato tenero con la nostra regione, facendosi beffe di tutto e di tutti, ma questo non vuol dire, è un po’ l’influenza austriaca, mi ha detto, strizzando le sopracciglia. La frase non era certo farina del suo sacco, perché lui la letteratura austriaca la conosce come io conosco le lingue uto-atzeche ma a questo ero abituato.
Io queste cose sono il primo a saperle, ma so anche che aveva qualche diffettuccio, ho ribattuto, mimando con le mani a pagoda un’alta montagna. Lui ha alzato gli occhi al cielo, perché con me alza spesso gli occhi al cielo, ormai è un riflesso condizionato. Pensa che abbia delle doti, ma che sia anch’io un grande rompicoglioni.Tutti gli uomini hanno difetti, ma quando si fa un necrologio li si dimentica, o insomma li si mette in sordina, magari citandone qualcuno sotto una veste comica, mi ha istruito.
Sono quindi uscito dal suo ufficio con vista sul parcheggio multipiano risultato della speculazione edilizia della quale non si può parlare, perché c’è di mezzo la curia, e la curia è la curia, anche nel duemilaventiquattro. Mi dicevo che tutte le frasi che mi venivano in mente non sono frasi che si dicono in un necrologio, che sarebbe stata dura. Cercherò di fare il mio meglio, ho finito per dirmi.
A casa però sono cominciati i problemi seri. Non mi veniva niente. Nemmeno una parola. Per la prima volta in vita mia avevo la sindrome della pagina bianca. Guardavo l’albero sotto il mio studio, e avrei voluto essere anch’io un tronco occupato solo a fare il tronco. Come mettere in avanti le sue qualità senza almeno dare un’idea degli imperituri difettacci che costituivano il suo marchio di fabbrica, come scindere le une dagli altri, inestricabilmente appiccicati? Come dire che scriveva delle belle cose senza specificare che a ben guardare era l’unica cosa che faceva bene, che era il solo e unico punto a suo favore? Come tacere che era un disastro in tutti i tipi di rapporti, che aveva sabotato via via tutte le sue relazioni famigliari e di amicizia e professionali e amorose, spesso e volentieri usando l’arma impudica della scrittura, ridicolizzando chi gli era più attaccato, rivelando indicibili dettagli intimi, sacrificando quello che è più prezioso, certo nella velleità di acchiappare lettori e sfornare un bestseller, cosa che non gli è mai riuscita, era il primo a saperlo? Come nascondere che l’unica cosa che gli premeva, l’unica per la quale aveva una morale, seppure svergognata, e una dignità, era scrivere, vale a dire saccheggiare le vite altrui? Come tacere il dubbio che fosse semplicemente un misantropo, un nuovo Pavese? Avevo accettato di buttare giù un pezzo che mai avrei potuto scrivere, un pezzo impossibile. Quando il mio vanto è quello di scrivere con brio e acume di qualsiasi cosa vogliono che scriva.
Il tempo passava, e la pagina del programma di scrittura rimaneva grigiognola. Grigiognolissima. Tanti pensieri, pensieri che non si potevano confessare, e nemmeno una riga scritta. L’albero cominciava a imbrunire, sembrava averne abbastanza di fare l’albero a mio uso e consumo. A un certo punto mi ha chiamato il caporedattore, con il suo solito tono un po’ seccato. Mi chiedeva se per cortesia potevo mandargli seduta stante il mio pezzo. Certo, ho risposto io.
Solo che questa volta non mi ero solo dimenticato di inviarlo, o anche avevo rimandato fino all’ultimo di scriverlo. Questa volta non potevo buttare giù una pagina in quattro e quattr’otto. Non perché non sapessi cosa dire, adesso, ma perché avevo troppe cose da dire. Troppe cose brutte. Tremende. Questa volta proprio non me la sentivo di scrivere quello che si aspettavano scrivessi. Poi quando l’albero ha acceso la lampada giallognola sul suo comodino mi sono lanciato, non potevo rimanere lì fino a mezzanotte. Farò quello che posso, mi sono detto. Ho scritto insomma quello che state leggendo.
Ecco, i caratteri che avevo a disposizione sono quasi finiti, e non ho detto poi molto del compianto (l’espressione che si usa in questi casi è questa) Giacomo Sartori. Un necrologio non può essere troppo lungo, anche la vita più avventurosa e rocambolesca – e non è il suo caso – viene a noia, se si tirano le cose troppo per le lunghe. La tensione cala, il pathos si annacqua, guastando perfino la commemorazione più struggente. Me li ha insegnati lui questi trucchi, o insomma mi ha insegnato a vederli più chiaramente di quanto non facessi prima. Per quanto riguarda la scrittura, e solo per questo, era implacabile anche con sé stesso. Questo non gli impediva peraltro di zigzagare nel balneario della letteratura nazionale come si rigirano gli elefanti nei negozi di bicchieri di cristallo, provocando crolli e cascate di rotture. E quindi a questo punto quello che è detto è detto, si avvicina l’istante del punto finale. La morte è anche proprio il cruento confronto con i limiti delle esistenze umane, con l’inettitudine delle parole nei confronti del mistero della vita.
Diciamo le cose come stanno, Giacomo Sartori non ci mancherà. Probabilmente quasi nessuno si accorgerà che non c’è più, nessuno si curerà della sua sofferenza di non avere avuto il riconoscimento che nel suo delirio altezzoso pensava di meritarsi. Un po’ mi dispiace, perché in fondo qualche qualità l’aveva, anche se forse dentro di lui – per quanto mi era dato vedere – tendeva a enfatizzarla un po’ troppo, e a nascondersi le pecche che tutti vedevano. Certo lui sarebbe molto contrariato, che non abbia tessuto i suoi elogi senza l’ombra di ombre o mezzitoni, come prevede il codice retorico dei necrologi. Così come certamente lo avrebbe indisposto essere presentato come un autore grandemente sottovalutato, un genio incompreso (avrebbe sparato a zero contro l’assenza del senso del ridicolo dei quotidiani di provincia), perché lui aveva sempre da ridire su tutto, ma questo aprirebbe un altro discorso ancora. Quel che è certo è che mi è impossibile non immaginarmi le sue reazioni, per assurdo che possa apparire. Qualche volta ho l’impressione di essere un suo clone, o anche un personaggio di sua invenzione, da tanto mi sento vicino. Ma forse il mio è solo timore di indispettirlo, visto che lo conoscevo bene, lui e la sua capacità di ferire. Non ho mai conosciuto nessuno che potesse essere così offensivo, così crudele, così violento, senza minimamente rendersi conto di esserlo. Pensando solo di dire la verità, un’utile verità. Forse ho solo paura dei suoi letali commenti. Certi riflessi sedimentati nel tempo, magari sarebbe meglio chiamarli traumi, sono duri a morire, sfidano anche la morte.
Ora è morto, almeno smetterà di criticare e di lamentarsi, dico a me stesso. I morti non possono prendersela, qualche vantaggio lo hanno anche loro, mi dico, senza riuscire a convincermi. Ma insomma anche i necrologi a un certo punto devono finire, come tutte le cose, e quindi rassegniamoci al fatto che anche questo finisca.
Questo racconto, dal titolo originario “Ricordando “Giacomo Sartori” è uscito sul numero 28 della rivista Fillide, dedicato alla parodia, con contributi di Domenico Scarpa, Paolo Albani, Gilda Policastro…:
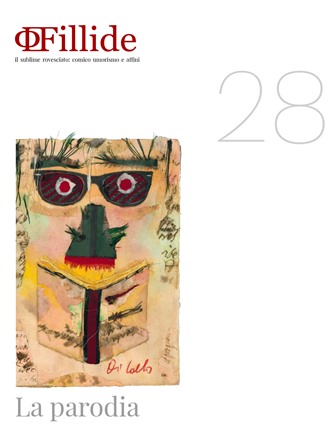
L’immagine: Louis Soutter, “Le Héros”, 1942 (da Wikiart)